PFAS: cosa sono, dove si trovano e i rischi per la salute
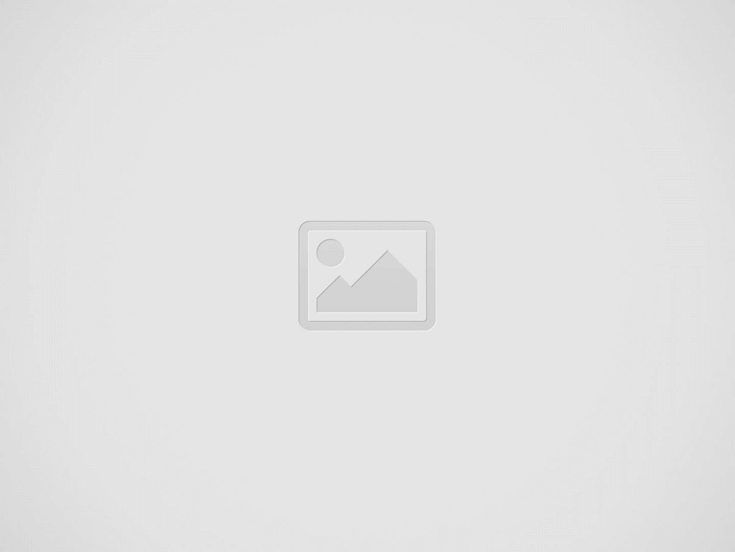
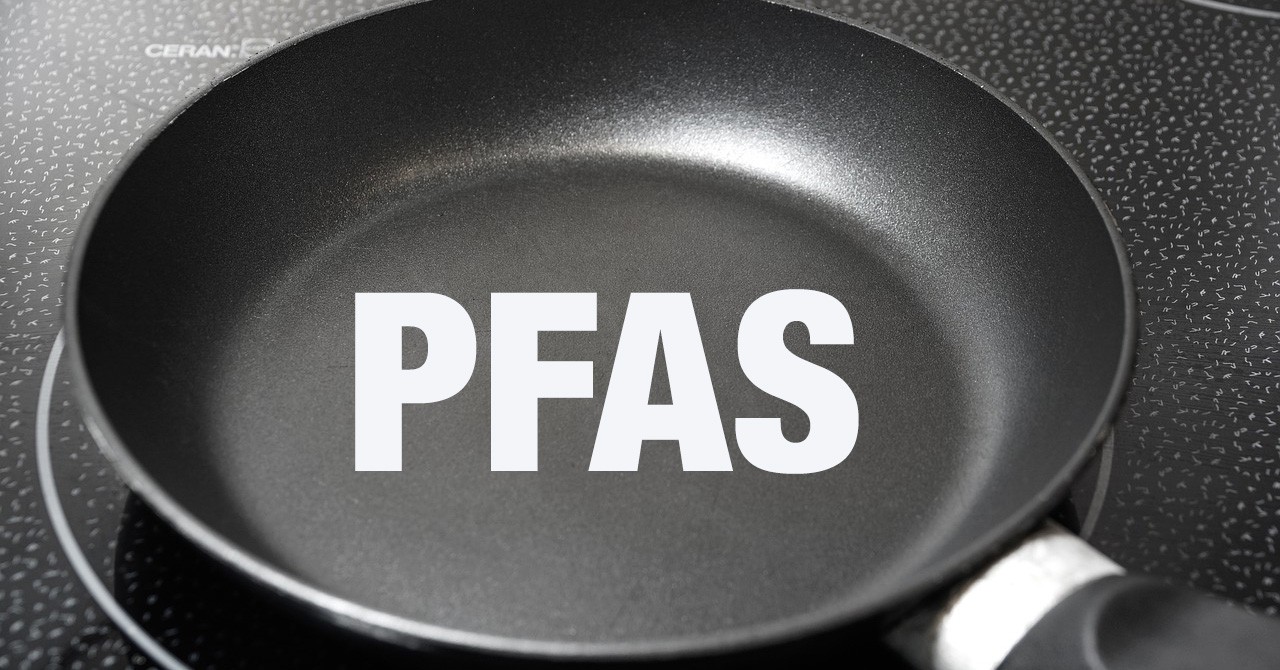
Pentola antiaderente, PFAS
Quello dei PFAS è un argomento ormai da qualche anno molto dibattuto. Fino a pochi anni fa la questione era sconosciuta ai più, ma oggi di queste sostanze chimiche si discute con sempre maggiore insistenza. Questo perché di recente si è scoperto che proprio i PFAS, largamente utilizzati in ambito industriale per la produzione di materiali diffusi in tutte le case, possono recare danni alla salute.
Ma cosa sono i PFAS nel dettaglio, dove si trovano, quali sono i rischi per il nostro organismo e come prevenirne gli effetti? Così come già accennato, la discussione sui PFAS si è diffusa nell’opinione pubblica soltanto di recente, sebbene la loro introduzione sul mercato risalga a parecchi decenni fa e, in particolare, con l’uso sempre maggiore di plastiche in ambito industriale.
I possibili effetti sull’uomo sono ancora largamente in fase di studio e, con molta probabilità, se ne saprà di più nei prossimi anni.
Di seguito, tutte le informazioni utili su questa delicata questione.
Cosa sono i PFAS
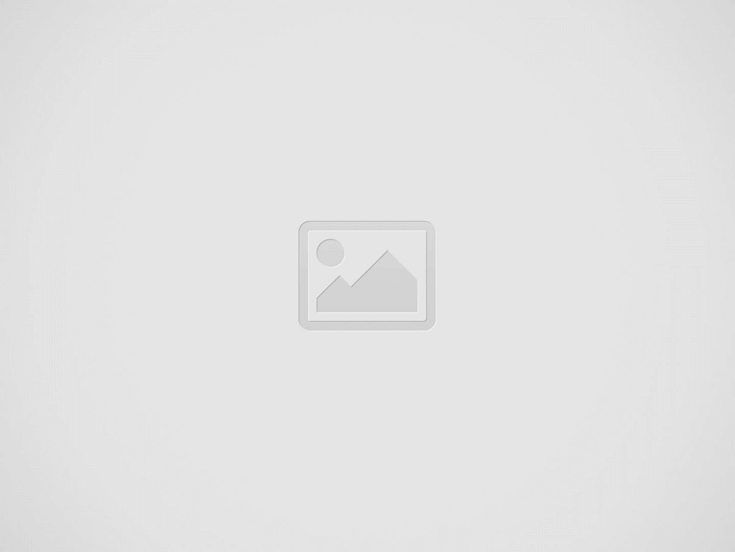

Con la sigla PFAS – acronimo inglese di PerFluorinated Alkylated Substances – si indicano alcune sostanze chimiche di produzione completamente umana, non presenti normalmente in natura. Noti anche come acidi perfluoroacrilici, si tratta di composti chimici dove è presente almeno un atomo di carbonio completamente fluorato.
In altre parole, si sta parlando di una famiglia di acidi di origine artificiale, formati da catene alchiliche idrofobiche, ideati per ottenere materiali particolarmente impermeabili sia all’acqua che ai grassi.
La definizione è complessa e, come facile intuire, non aiuta la comprensione di chi si avvicina per la prima volta a questo tema. Per semplificare, si possono definire come PFAS tutte quelle sostanze chimiche dove viene creato almeno un legame molto stabile tra carbonio e fluoro, una combinazione che aumenta l’impermeabilità all’acqua e ad altri liquidi oleosi.
Le due tipologie di acidi perfluoroacrilici più diffuse sono i PFOA, acido perfluorottanoico e i PFOS, acido perfluorottanosulfonato. Questi vengono impiegati in campo industriale sin dagli anni ’50, soprattutto per la produzione di materiali plastici e leghe.
Oggi si trovano in molti oggetti di uso comune: dalle pentole antiaderenti ai tappeti, passando per schiume antincendio, pelli artificiali, vernici, detersivi e molto altro ancora.
Nonostante il loro uso inaugurato ormai molti decenni fa, solo di recente si è scoperta la loro pericolosità per la salute umana e animale, con la possibilità di contaminazione sia della catena alimentare che delle aree naturali di cui normalmente l’uomo si serve.
Per cosa vengono utilizzati i PFAS
Come già accennato nel precedente paragrafo, i PFAS da tempo rappresentano una risorsa molto diffusa in ambito industriale per la produzione di numerosi materiali. Questo perché la loro elevata idrofobia – cioè la capacità di respingere l’acqua – ha aperto la strada per lo sfruttamento massiccio di questi composti chimici per moltissime necessità umane. Di norma, vengono utilizzati per:
- Impermeabilizzare la carta e i suoi derivati, così da ottenere contenitori per alimenti che possano resistere sia all’acqua che ai grassi;
- Proteggere le fibre dei tappeti e di altri tessuti dall’azione dell’acqua, per facilitarne l’asciugatura o ridurre l’accumulo di polvere e altri detriti;
- Aumentare l’efficacia di moltissime soluzioni anti-incendio, come le schiume presenti all’interno degli estintori;
- Ottenere tessuti tecnici da utilizzare anche in presenza di intemperie, come gli impermeabili da lavoro, o capaci di repellere il sudore per le soluzioni sportive;
- Rivestire le pentole con uno strato anti-aderente che, non legandosi né all’acqua né ai grassi, impedisce agli alimenti di attaccarsi alla stessa pentola.
Dove si trovano i PFAS
Considerato il loro uso massiccio in ambito industriale, i PFAS sono ormai ubiquitari nella nostra quotidianità: come già ripetuto, sono presenti in una lunga serie di prodotti di uso molto comune. Questi possono comprendere:
- Tessuti impermeabilizzati per la casa e l’arredamento, come tappeti e tende;
- Indumenti tecnici da lavoro o sportivi, sia impermeabili che “scaccia-sudore”;
- Moquette, coperte in fibra sintetica e panni, sempre sintetici, per le pulizie;
- Prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa come filo interdentale, cere per pavimenti, detergenti schiumogeni sia per il corpo che per le superfici;
- Strumenti a base di schiuma per spegnere incendi, come gli estintori;
- Accessori anti-aderenti da cucina, come pentole e padelle;
- Contenitori in plastica e altri derivati per gli alimenti;
- Vernici e rivestimenti applicate sui mobili prima della vendita.
Ma data la loro elevata diffusione, come ne entriamo in contatto? In che modo avviene la contaminazione da queste sostanze chimiche di cui oggi si conosce la loro pericolosità?
Contaminazione alimentare
La prima fonte di contaminazione da PFAS per l’uomo è quella alimentare. Diversi studi, ad esempio quello condotto dall’Istituto Superiore della Sanità nel 2017, hanno dimostrato come molti cibi consumati quotidianamente contengano vari livelli di PFAS. Questi alimenti entrano in contatto con gli acidi perfluoroacrilici con due diverse modalità:
- Contaminazione diretta: avviene quando i cibi vengono conservati in contenitori e involucri che contengono PFAS, che possono quindi trasferirsi dal contenitore agli stessi alimenti;
- Contaminazione indiretta: poiché usati in ambito industriale, presenti in alti livelli negli scarichi delle stesse industrie, tramite i flussi dell’acqua i PFAS possono raggiungere i terreni, contaminando così le coltivazioni. Per la stessa ragione, possono contaminare anche i prodotti ittici.
In particolare, i PFAS sono stati rinvenuti in carne, pesce, uova di gallina, latte, verdura a foglia verde, tuberi, frutta e agrumi.
Contaminazione ambientale
La contaminazione da PFAS può avvenire anche per via ambientale, ossia per contatto diretto o indiretto nei luoghi in cui si vive o si trascorre molto tempo. Anche in questo caso, si possono riassumere due principali modalità:
- Contaminazione diretta: poiché i PFAS sono decisamente diffusi in oggetti e strumenti di uso comune, una certa quantità viene assorbita dall’uomo nei luoghi di vita, attraverso l’uso di detergenti, pentole e padelle, tessuti e prodotti per l’igiene personale;
- Contaminazione indiretta: poiché presenti negli scarichi industriali, ma soprattutto nei rifiuti, la contaminazione è ambientale anche in senso lato. Alti livelli di PFAS sono stati infatti rilevati negli spazi urbani e in diverse aree verdi o agricole.
Rischi dei PFAS per la salute
Ma quali sono i rischi dei PFAS per la salute? Come già ribadito più volte, la scoperta della pericolosità di queste sostanze chimiche è relativamente recente e gran parte degli studi sono ancora in corso. Nel 2020, l’EFSA – l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – e l’EAA – l’Autorità Europea dell’Ambiente – hanno raccolto alcune delle ricerche più interessanti, elencando i fronti di principale preoccupazione
Effetti endocrini e ormonali
Gli studi hanno innanzitutto evidenziato degli effetti endocrini e ormonali dovuti all’esposizione a queste sostanze chimiche. I PFAS possono infatti interferire con le normali funzionalità della tiroide, determinando:
- Ipotiroidismo e ipertiroidismo;
- Pubertà precoce nei bambini;
- Alterazioni nello sviluppo delle ghiandole mammarie, dei genitali, delle ghiandole riproduttive (ovaie e testicoli) e nell’apparizione dei caratteri sessuali secondari, come i peli corporei;
- Infertilità maschile, con una bassa concentrazione di spermatozoi, impotenza.
Effetti immunitari
I PFAS agirebbero anche sul sistema immunitario umano. Uno degli ultimi effetti scoperti dalla ricerca biomedica riguarda la riduzione della risposta dell’organismo alle vaccinazioni, soprattutto nei bambini. Queste sostanze chimiche, in altre parole, rendono il sistema immunitario meno sensibile alla sollecitazione indotta dai vaccini, riducendone l’efficacia.
Ancora, sembra possano essere una delle cause di alcune patologie autoimmuni, poiché possono stimolare iper-attività a livello di risposta del sistema immunitario.
Effetti tumorali
L’esposizione prolungata a queste sostanze chimiche può favorire lo sviluppo di alcune forme tumorali, alcune delle quali di difficile cura. La maggiore correlazione è stata rinvenuta con:
- Cancro della mammella;
- Cancro del rene.
Effetti sul metabolismo e sul cuore
Infine, i PFAS interferiscono con numerose funzioni metaboliche, con conseguenze dirette a livello cardiaco. Sembra infatti che queste sostanze possano favorire l’obesità e, fattore ancora più preoccupante, l’assorbimento di colesterolo cattivo tramite l’alimentazione e la sua produzione spontanea da parte dell’organismo.
Ancora, possono provocare danni al fegato, all’apparato digerente e sembrano essere tra i primi responsabili di malattie croniche a livello intestinale.
Come proteggersi dai PFAS
Ma come proteggersi dai PFAS, considerata la loro presenza pressoché ubiquitaria nelle nostre case? Al momento, non vi sono delle precise linee di difesa, almeno finché non vi saranno normative particolarmente rigide per ridurne – o eliminare del tutto – il loro impiego. Vi sono però alcuni consigli di buon senso:
- Evitare l’acquisto di prodotti alimentari confezionati, se a diretto contatto con plastica, pellicole per l’assorbimento dei grassi o involucri impermeabili;
- Non utilizzare pentole o padelle che presentano uno strato anti-aderente non integro;
- Acquistare frutta e verdura da coltivatori certificati, preferibilmente da agricoltura biologica e abituati a controlli continui e verificabili delle concentrazioni di inquinanti nei loro terreni;
- Prestare attenzione ai prodotti per l’igiene personale e per la cosmesi, soprattutto quando “resistenti all’acqua”, poiché possono contenere alti livelli di PFAS;
- Evitare tessuti tecnici o sintetici impermeabilizzati, preferendo fibre naturali.
Fonti
- Cosa sono i PFAS – Agenzia Europea Ambiente;
- Effetti sulla salute dei PFAS – Agenzia Europea Ambiente;
- PFAS e contaminazione alimentare – EFSA;
- PFAS e cibi in Italia – Avvenire/Istituto Superiore di Sanità;
- PFAS – Wikipedia.